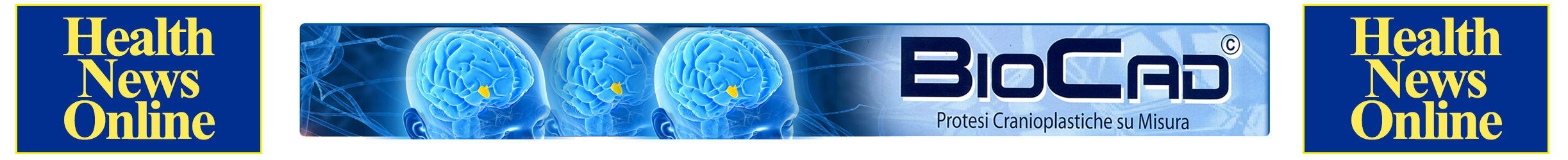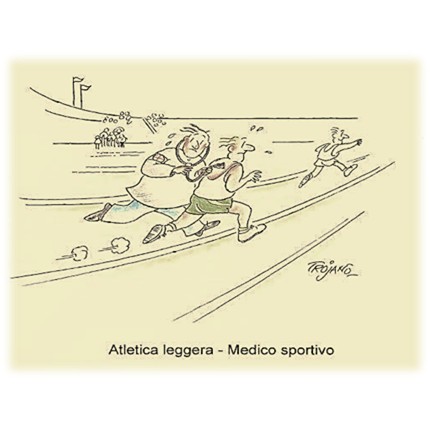Disposofobia, hoarding disorder, disturbo da accumulo compulsivo: variegata la terminologia per indicare una problematica apparentemente bizzarra ed insolita che, recentemente, è riconosciuta dagli addetti ai lavori come un disturbo a sé, con una propria dignità nosografica e clinica. Eppure, sarà capito a tutti almeno una volta nella vita di faticare a staccarsi da un oggetto, cui tenevamo particolarmente tanto da peregrinare insieme ad esso nelle varie tappe della vita e considerarlo come parte della “nostra storia”. Malgrado la nostra natura mutevole di essere umani, i nostri oggetti ci aiutano a ritrovare noi stessi, la nostra identità al punto che il biglietto del cinema della prima uscita con nostra moglie diviene un’estensione di noi stessi. Tutto ciò sembra, infatti, trovare significato in termini evolutivi: “mettere da parte per i tempi di magra”, essere previdenti -in tal senso- si pone come un comportamento funzionale alla nostra sopravvivenza. Può capitare, però, che la situazione sfugga di mano. Ma non basta essere particolarmente legati ai propri oggetti. La situazione sembra prendere una piega diversa quando inizia ad esserci un’enorme difficoltà a stabilire delle priorità, quando si perde di vista il rapporto costi-benefici nel conservare gli oggetti. Ed è proprio questo che demarca la linea di confine tra normalità e patologia, o meglio tra la funzionalità e la disfunzionalità del conservare le cose ed accumularle. In tal caso, invadere e rendere inutilizzabile parte della casa per conservare una grande mole di oggetti, credendo che, forse, prima poi qualcuno di essi potrebbe rivelarsi utile, ha poco di vantaggioso se non evitare il dolore e l’ansia che segna il distacco dalla “roba”. Nel disturbo da accumulo, infatti, buttare e disfarsi degli oggetti sembra essere molto tormentato tanto che si è disposti a non farlo, a procrastinare pagando costi enormi che, a volte, si identificano con la propria sopravvivenza, come nel caso dei fratelli Collyer. Noto alla stampa del tempo e passato alla storia come uno dei casi più eclatanti di accumulo compulsivo è quello di una coppia di fratelli newyorkesi che, nel 1964, ha dato prova che “di troppe cose” si può morire: uno dei due morì schiacciato da un crollo di oggetti ammucchiati e il fratello paralizzato, morì di fame.
Ma, allora, qual è la spiegazione a tutto ciò? Cosa accade nella mente dell’ accumulatore? Ciò che spinge e motiva un accumulatore ad accumulare, appunto, non sembra essere molto diverso da ciò che riporta la popolazione non clinica. Dall’attaccamento emotivo all’attribuzione di alta funzionalità relegata agli oggetti piuttosto che il valore intrinseco degli stessi senza tralasciare l’attribuzione di significato identitario, che ben si esprime in frasi del tipo “E’ come se le mie cose fossero dei figli”: queste le motivazioni alla base dell’accumulo. Senza dimenticarne, però, ulteriori come l’interesse per l’aspetto estetico o funzionale di cui un oggetto può godere tanto da spingere alcuni studiosi ad identificare il maggior motivo sottendente alla condotta accumulatoria con il “genuino piacere di possedere gli oggetti in modo da conservarli, usarli, goderne, regalarli o riciclarli” (Pertusa e coll. 2010, p.1018). Tutto questo set motivazionale sembra, però, assumere ulteriore significato alla luce di una serie di credenze e di scopi che animano la tendenza all’accumulo e, quindi, la difficoltà di disfarsi della roba. Semplificando: conservare degli oggetti alla luce di una motivazione affettiva che rende ogni oggetto speciale poiché connesso con la propria identità, spiegherebbe lo speculare disinteresse verso l’oggetto stesso e verso tutto ciò che esso veicola nel caso in cui si cerca di disfarsene così da giustificare il sentimento di pena e un vissuto di colpevolezza nello svalutare, gettandole, parti di sé e della propria identità. Oppure, la credenza secondo cui dimenticare o perdere i ricordi equivarrebbe a perdere pezzi di sé e dei propri affetti da significato all’accumulo in quanto legato al voler catturare il tempo, preservandolo. O, ancora, credere che disfarsi degli oggetti si associ a superificialità per non dar loro il giusto valore, alimenta la motivazione ad accumulare la roba per fini utilitaristici. Queste credenze sottendenti il comportamento accumulatorio riflettono la loro importanza nel pattern di risposte emotive di disagio associate al distacco dalle cose. Ciò che lega un accumulatore ai propri possedimenti sembra, quindi, avere a sua volta un particolare legame con un pattern di credenze relative alla responsabilità, all’attaccamento emotivo, al preservare i ricordi, al controllo secondo cui conservare gli oggetti in un certo luogo e modo relega un senso di sicurezza. Alla luce di quanto appena esposto, risulta più facile comprendere ciò che accade nella mente di un accumulatore, che riconoscendo se stesso nei suoi averi e nutrendo per essi responsabilità e bisogno di controllarli, avverte forte angoscia e disagio alla sola idea di potersene distaccare tanto da provare emozioni positive nella speculare tendenza all’accaparramento di un oggetto. La stessa emozionalità positiva funge, a sua volta, da rinforzo al continuo acquisire roba, traducendosi in un’esperienza piacevole. L’identikit del disturbo da accumulo si completa accostando, all’importanza giocata dalle credenze e dagli scopi, una fetta di evidenze che documentano la presenza di deficit cognitivi relativi alla capacita di prendere decisioni, al problem solving, alla memoria e all’attenzione. Gli stessi si riflettono a livello cerebrale in un anomalo funzionamento di aree cerebrali sottendenti tali capacità nonché ad altri marker neurobiologici ed anatomici. E questo fa strada ad un’ intrigante questione. Nel determinismo del disturbo da accumulo, la natura della relazione causale tra l’aspetto neurobiologico e quello psicologico non sembra aver trovato, ad oggi, risoluzione. Dinanzi ad interrogativi che si domandano se vi sia una predisposizione neurobiologica che porta a sviluppare il disturbo; oppure, se quest’ultimo sia legato alle determinanti psicologiche, risultanti in un anomalo funzionamento cerebrale, autori sottolineano la necessita di ulteriori indagini, in tal senso. Pur convenendo con questi ultimi, sento di avanzare alcune riflessioni, in merito, che mi farebbero propendere ad ipotizzare l’importanza del fattore psicologico e con esso delle credenze e degli scopi. Tra queste: l’evidenza per cui un danno cerebrale acquisito a carico di regioni malfunzionanti nel disturbo da accumulo, esita in una condotta comportamentale accumulatoria in termini di collezionismo indifferenziato, che ben si discosta, però, dalla tendenza all’accumulo guidata dallo scopo diretto ad acquisire, in cui vi è la mediazione di variabili di tipo cognitivo ed affettivo. La medesima mediazione cognitivo–affettiva potrebbe, a mio parere, rispondere alla modulazione funzionale di alcune aree cerebrali in risposta all’induzione sperimentale di sintomi di tipo accumulatorio, indagati attraverso la risonanza magnetica funzionale. L’insoluto interrogativo ci rimanda ad un dato di fatto che ritrae la limitatezza della ricerca riguardante tale disturbo. I medesimi limiti si ritrovano anche nel fatto che, ad oggi, non risulta del tutto chiaro quale sia il trattamento d’elezione e, soprattutto, la sua efficacia. A complicare il quadro vi è un ostacolo al trattamento: ossia, la scarsa motivazione dei pazienti alla terapia risultante da una altrettanto scarsa consapevolezza del disturbo. Verrebbe, quindi, da chiedersi “ma è un disturbo che si cura?”. Sebbene lo scarno corpus di evidenze in merito, appaiono molto incoraggianti i dati di un significativo miglioramento della sintomatologia di tipo accumulatorio in risposta alla terapia cognitivo comportamentale (TCC), come riportato da Steketee e coll. (2010). Lo scopo del trattamento è addestrare i pazienti ad imparare a sopportare di più la sensazione di buttare via qualcosa di importante, avvalendosi anche di una parte di trattamento basata sull’Esposizione con Prevenzione della Risposta (ERP). Nell’ERP si aiuta, infatti, il paziente ad esporsi gradualmente al pensiero, all’immagine o all’evento temuto facendo in modo di resistere all’impulso di accumulare. Insieme al terapeuta, infatti, il paziente imparerà a tollerare la situazione minacciosa “buttare un oggetto personale” piuttosto che “non comprare qualcosa di conveniente” , cercando modi alternativi all’accumulo per rispondere alla situazione problematica.
Dr.ssa Annalisa Bello
Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale
Dottore di Ricerca in Neuroscienze Cognitive
Membro del gruppo di ricerca in Psicopatologia Sperimentale APC-SPC di Roma
www.psicoterapiaclinica.it